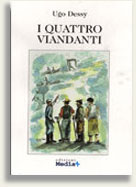
I QUATTRO VIANDANTI
Racconto / edizioni Media + / Cagliari 2005
seconda pagina di copertina:
Quando gli uomini si sono incontrati,
non si separano più.
Anche quando si sono lasciati,
si ritrovano tutti in ognuno di loro.
In ogni uomo ci sono tutti gli uomini
del mondo e tutte le stelle del cielo.
quarta pagina di copertina:
Su questo racconto, Geno Pampaloni, della Vallecchi, in data 11 luglio 1966 scrive:
"Caro Dessy, abbiamo letto I quattro viandanti: è un'opera nobile, ben scritta, ma così poco "narrativa"! Ha quasi il ritmo della prosa d'arte, è piena di lenta meditazione e di appassionata difesa umana. Ma non è adatta ai nostri Narratori Vallecchi".
Esattamente quattro anni dopo, nel luglio del 1970, Gian Giacomo Feltrinelli legge e pubblica entusiasta I quattro viandanti nella Collana I Narratori - grandi autori moderni di tutto il mondo.
I QUATTRO VIANDANTI
Il minatore si levò per primo, stordito. Volle resistere, aggrappandosi al pulviscolo misto al fumo denso che saliva dalla carcassa; ma una nuova ondata lo investì trascinandolo nel turbinio sempre più in alto.
Uscito dal vortice si fermò, per snebbiarsi. Volse lo sguardo in basso e vide il rogo lontano, piccolo come focherello di sterpi. Ebbe curiosità di sapere che cosa fosse accaduto agli altri.
Il contadino uscì obliquo dalla nuvola di fumo, con il suo cesto sottobraccio. Trasse un fazzoletto e si asciugò gli occhi. Guardò intorno, vide il minatore, e si diresse verso di lui, con una vaga espressione di gioia sul volto.
«Aspettiamo?» chiese.
«E' meglio,» rispose l'altro, «forse facciamo la stessa strada.»
Il pastore e il pescatore arrivarono uno dietro l'altro. Avevano udito la frase, ma i loro occhi erano ancora opachi. Per ciò chiesero:
«E chi dice che facciamo la stessa strada?»
«Guardate,» rispose il minatore, «ce n'è una sola, questa dove ci troviamo.»
Il contadino guardò e vide. «Strano,» mormorò deluso, «credevo ci fossero tre strade…»
Il minatore sorrise. «Ed io invece ero convinto che non ce ne fosse alcuna, dopo…» disse.
«Non bisogna mai credere a ciò che non si vede.» Sentenziò il pastore.
Anche il pescatore pensò di dover dire la sua: «Forse è ancora troppo presto, per sapere…»
Il contadino capì, bilanciò il manico del cestino sul braccio e fece per muoversi. Pensò: E voi, non avete bagaglio?» Guardò e vide che la domanda era inutile. Disse: «Avviamoci. Ho idea che il viaggio sarà lungo.»
«Sapete, è da tanto tempo che desideravo fare un viaggio in compagnia. Ci sembrerà più breve, chiacchierando,» disse il pastore, incamminandosi.
Gli altri lo seguirono sulla strada che si snodava come un serpente grigio sospeso nell'azzurro.
Camminarono senza tempo, fino a sentirsi stanchi. Poi sedettero sull'orlo della strada, con le gambe penzoloni nel vuoto.
«Se c'è una sola strada, vuol dire che siamo tutti uguali.» Pensò e disse uno.
«Non mi pare,» protestò subito il contadino, indicando i compagni, «io sono contadino, ma tu sei pastore... e tu pescatore, si vede… e tu minatore, anche tu, si vede… Non mi pare che siamo uguali.»
Il minatore ripeté: «Se facciamo la stessa strada, vuol dire che siamo uguali. Di fuori sembriamo diversi; di dentro siamo uguali.»
«Dentro, io porto la mia vita. Come è possibile che la mia vita sia uguale alla tua?» Insisté il contadino.
«Non lo so bene; lo credo. Racconta la tua vita, così sapremo.»
«Abbiamo tutto il tempo per sentire e per parlare… Anche io vorrei dire la mia vita.» Intervenne il pastore.
Il pescatore assentì. Fece un cenno di incoraggiamento al contadino. Disse: «Forza, racconta… Peccato, che non abbiamo vino!»
Gli altri sorrisero.
Alle sei del mattino la corriera era partita da Sassari, vuota come al solito, perché i viaggiatori se li trovava strada facendo, nei paesi non attraversati dalla ferrovia.
Ai primi tornanti erano apparsi boschi densi di querce tralucenti nel vermiglio dell'alba. A lato della strada un lieve riflesso rosa sfiorava i cespugli di oleandro già gonfi di foglie e di fiori.
Si era fermata al primo villaggio - casupole di schisto e viottoli acciottolati - per un contadino, un uomo come tutti gli uomini che zappano terra dura.
Il contadino era salito scrutando l'interno. S'era seduto accanto al finestrino, verso l'alba. Aveva sistemato il cestino tra i piedi; aveva appoggiato le mani sulle ginocchia e volto la faccia al paesaggio - lasciandosi cullare dal molle sussultare del sedile, assopendosi al rotolio monotono.
Le montagne aspre si allontanavano sfumando all'orizzonte tra nubi turchine dai riflessi di madreperla. La strada degradava su colline coltivate a vigna. Nelle brevi vallate nereggiavano ulivi, e schiere di tordi vi sfilavano da ponente a levante.
Nei sentieri incassati tra muretti di pietra, lungo i binari di antichi solchi, scorrevano i carri a buoi, traballando ad ogni roccia affiorante, con gli uomini a lato a pungolare o raffrenare il passo delle bestie.
Sopra ogni carro, l'aratro e la bisaccia; nella bisaccia, il pane e la zucca; nella zucca, il vinello aspro di ogni giorno.
Nei viottoli - strisce battute ai margini dei campi - andavano i braccianti con la zappa a spalla. Già popolavano la campagna, diretti in ogni dove, incrociandosi, salutandosi mutamente con un cenno di mano o con un breve levar la faccia da terra - creature aggiogate ad un invisibile giogo.
Poi i colli si erano fatti più distesi, ed erano apparsi i grani, recinti dalle siepi del fico d’india. All'orizzonte si era levato rosso il disco del sole.
Il contadino si era scosso. Era la sua vigna, quasi in cima al colle, con l'ulivo piantato nel mezzo… La sua casa; il tepore della stuoia davanti al camino; il greve respiro dei piccoli addormentati sul letto grande; l'ombra della sua donna accoccolata intenta a scaldare sulle braci il caffè d'orzo. La sua era una delle case intorno alla piazza - muri di fango imbiancati di calce.
Aveva atteso la corriera nella piazza deserta, davanti alla porta della bettola. Si popolava ogni sera di voci, di scalpiccio di scarpe chiodate. Nell'angolo buio della stanza, la botte riempiva di rosso i boccali. Spruzzati di rosso erano il pavimento di cemento e le camicie di cotone. Scioglieva i grumi degli assilli, placava le ansie, addolciva i tumulti. I cieli diventavano azzurri e si popolavano di angeli rosa. I colli si riempivano di messi prodigiose, più alte della spalla dell'uomo, e gli ulivi piegavano i rami, sotto il peso di frutti innumerevoli. Sole e pioggia, brezza e bonaccia si alternavano come strofa e ritornello di un mottetto d'amore. Le aie non bastavano a contenere le montagne di spighe; né cavalli, né buoi, né braccia di fanciulle e di ragazzi bastavano a trebbiare tutto quel grano che scorreva come un fiume giallo; né sacchi, né teli, né coperte bastavano a raccogliere la pioggia di semi; né magazzini, né tettoie, né cortili bastavano al sogno di ogni sera, fra le quattro mura della bettola, in piazza…
Il contadino aveva visto i colli rifarsi aspri e rocciosi. Erano riapparse vigne, col fico accanto alla baracca del guardiano. Gli ulivi diradavano; nelle vallate scorrevano torrenti colmi di ciottoli, di arene, di serpi, di cespi di euforbia.
«Mi chiamo Orrù Gavino, di quarantacinque anni, con moglie e sei figli. Mio padre contadino nullatenente, con sacrificio di molti anni, facendo il salariato fisso, riuscì a farsi la casa. Venuta la Grande Guerra lasciò moglie e un bambino. Fu ardito della Brigata Sassari, con pugnale e bombe a mano, benvoluto dai capi. Visse lungo tempo attendente di ufficiali, tra i quali un cappellano, uno di quei preti un poco onesti che gli incominciò a illuminare il mondo di una luce che lui non conosceva. Allora capì che la guerra era una truffa, e quando ritornò in paese scese in piazza in divisa di ardito per fare giustizia, con pugnale e bombe a mano. In molti lo seguirono, per fare giustizia; e in molti lo seguirono in prigione, perché il picchetto armato aveva circondato e arrestato metà della gente. Dopo un anno ritornò a fare il salariato fisso, fino a quando si procurò l'indipendenza. Il 14 aprile mia madre mi partorì e mi chiamarono Gavino in onore del santo patrono. Venuto all'età di sei anni cominciai ad andare a scuola. Di carattere espansivo e sorridente, mio padre mi amava sempre di più per simpatia che gli rassomigliavo in tutto. Quando non si faceva scuola, il giovedì e la domenica, andavo in campagna a pascolare le due capre. Completate le scuole, le capre divennero quattro. Nel 1933 col solo latte si guadagnava lire quindici al giorno. La serietà in famiglia era di lavorare tutti per una sola cassa. Quando mancavano i soldi in tasca portavo fasci di legna. Scherzando mi chiamavano "fascista", ma pagavano tre soldi il fascio e mi ricordo che il defunto padre diceva: "se lavoriamo tutti insieme ingrandiremo la casa." Il 1937 venne il riselciamento di alcune strade del paese e non volli più pascolare le capre. Ancora non avevo compiuto il sedicesimo anno quando andai a domandare all'impresa se mi occupava a disselciare. Difatti mi fecero il libretto di lavoro che conservo col numero tre. Altro che andare in campagna a pascolare, con una paga sicura… La sera mi dilettavo leggendo romanzi, Tristano e Isotta e i Cavalieri della Tavola Rotonda… A diciassette anni domandai a mia madre se potevo andare a scuola di musica. Lei mi rispose: "Perché non vai da don Luca che suona l'armonium in chiesa?" Era la musica che desideravo imparare, in quel momento… Dopo quindici giorni sapevo tutta la teoria, e in sei mesi ero secondo clarino. Una vita piena di sacrificio ma bella. Si camminava ogni domenica a piedi con la banda, da un paese all'altro, e tutta la settimana a lavorare. Un giorno che non dimenticherò mai fu quel 7 di dicembre del 1939. L'acqua si portò via il grano e insieme la terra. Tutta la gente correva, con le case allagate… Poi, il 1940, avevamo trebbiato paglia, nelle aie. Lo stesso anno mio fratello partì richiamato alle armi, e dovetti abbracciare la croce di tutto il lavoro dei campi. In novembre chiamarono anche me a fare la guerra… Una cosa mi ha sempre salvato: l'ordine della famiglia, come il padre ci educò. Tutto il guadagno, di qualsiasi natura, doveva essere corrisposto alla madre, quale ottima amministratrice, che fino a ottantasei anni usciva ogni sera a raccogliere una fascina per la cena. Alle sei di tutte le stagioni, che corrisponde all'imbrunire, il campanone suonava. Avevamo dieci minuti di tempo per rincasare, il tempo di riscaldare la minestra e mettere i piatti sul tavolo. Dopo si mangiava. Chi di noi figli non era rincasato non mangiava. Di mattina presto lei sempre alzata, con il caffè d'orzo pronto per chi doveva uscire a dar la paglia ai buoi. Un'ora prima di far luce riscaldava la minestra e preparava la bisaccia col pane e la zucca del vinello. Mia madre era donna di poche parole, e quando parlava non le piaceva ripetere. Ricordo la sera di Sant'Isidoro, il 17 settembre del1936. Eravamo andati tutti a sentire la gara poetica in piazza, e qualcuno che ci voleva male aveva appiccato il fuoco alla legnaia. Il pericolo era grande, ma lei ci spingeva avanti gridando: "Forza, vigliacchi! non vedete che brucia la casa? Forza coi secchi!" Nel 1945, tornato dalla guerra, presi moglie in casa, e la madre allora mi diede il pezzo di terra che mi spettava… Non so, forse stavo meglio salariato fisso - anche se il lavoro nostro è di cento giorni soli per un anno. La terra è una catena che non si può rompere, se non si vuol perdere quel poco pane che dà. Finito di zappare il mio poco, andavo bracciante con l'uno e con l'altro. Il mio lavoro si sa: arare, zappare, sarchiare, diserbare grano… Tutti i giorni così, da quando fa luce a quando fa buio. A casa, nemmeno la forza di spogliarsi per mettersi a letto. Uno si butta sopra la stuoia e si addormenta come una pietra, senza neanche sentire le parole di tribolazione della sua donna che ha addosso la fame di tutti i figli… Tante volte ho pensato: "Eh, se avessi qualche anno di meno! già non me ne resterei qui, a puzzare…" Ma dove potevo andare io a sbattere la testa, io che altro non sapevo fare se non tenere la zappa in mano? Ma quando la fame è da tagliare a fette, quando l'acqua ti arriva alle costole, allora ti muovi, sì… Andavo a Cagliari, per espatriare. Mi avevano detto che in terra straniera prendono anche contadini, se hanno braccia buone…»
Stettero assorti a lungo.
Il contadino li guardò uno ad uno, in ansia di sentire una parola, magari di commiserazione. Si stancò di attendere e disse: «Lo so, la mia vita non vale un soldo bucato. Neanche il tempo che ci vuole ad ascoltarla, vale.»
Gli altri tacevano a testa china.
Rompendo il silenzio, il minatore disse: «E' la vita di un uomo. La vita di tutti gli uomini che cercano pane con le mani.»
«No. Non posso credere che sia così per tutti. Io conosco il pastore. Non è così. E' libero, lui… e fa più danni delle cavallette e della brina. Ho assaporato il gusto di spararne qualcuno, trovando il grano devastato dalle pecore…»
«L'ho pensato anch'io, Orrù Gavino, quando tu e la tua razza avete invaso le terre incolte affamando le greggi.» Lo interruppe aspro il pastore.
Il pescatore interloquì: «Io non c'entro con le vostre terre pietre di pietre e di merda! Non sono come voi, io. Eh, se non avessi avuto sulle spalle i padroni delle paludi…»
«Lasciamo andare.» Tagliò corto il minatore. «Sembriamo un branco di cani litigiosi. Ci siamo fermati abbastanza. E' tempo di riprendere il cammino. Sono curioso anch'io di sapere dove andiamo, di sapere se siamo diversi.»
Si levarono, scuotendosi con la mani la polvere grigia dal fondo dei pantaloni.
Sulla linea dell'orizzonte intravvidero il ricordo della terra, lieve come una nuvola bianca d'estate. Il nastro grigio non saliva più; si snodava in dolci tornanti perdendosi dietro una parvenza di colle verde. Il contadino ebbe nostalgia di quel colle, ma non lo disse. Si avviò per primo. Gli altri gli tennero dietro.
Camminarono con lena fino a sentirsi le ginocchia molli. Il pastore si asciugò il collo e la fronte con un gesto abituale. «Non c'è sole, né stelle, in questo cielo…» mormorò turbato.
I compagni levarono gli occhi in alto, ed ebbero un brivido di sgomento.
«Perché ho preso questa strada, con voi?» Esclamò il contadino, impaurito e diffidente, fermandosi. «Non vi conosco neppure, io…»
«E che altra strada vuoi fare, Orrù Gavino?» Gli rispose il pastore risentito. «Puoi sempre tornare indietro, se vuoi.»
«Tornare indietro…» mormorò l'altro, soprappensiero. «Certo, torno indietro… subito, me ne torno indietro! Cercherò un'altra strada, io… dove ci sia gente della mia razza. Tre, ce ne devono essere di strade!» Si voltò agitato, fece per muovere un passo, ma si arrestò, agghiacciato dall'orrore: il nastro grigio finiva alle loro spalle; nell'immenso baratro azzurro. Crollò a terra. Si accovacciò con la faccia sulle mani, piangendo senza ritegno. Poi levò il capo, vide i compagni e corse da loro.
Uno gli pose una mano sulla spalla. «Che cosa vuoi tu, Orrù Gavino? Che paura hai tu dell'inferno, se ne sei uscito appena adesso?»
«Non so, non so…» gemette il contadino. Si sentiva più misero, più incerto, più infelice degli altri. «Io sono diverso. Tutta la mia vita ho trascinato, io… Che giustizia è questa, se c'è una strada sola per tutti gli uomini, per i buoni e per i cattivi, per chi ha sofferto e per chi ha rubato?»
Il minatore attese a lungo che qualcuno rispondesse. Dopo, parlò: «Orrù Gavino, la giustizia, gli uomini se la devono fare loro. E' cosa da uomini, la giustizia. Tutti ce l'abbiamo nell'idea, la giustizia. Solo che bisogna patire per farla.»
Il contadino non capì. Neppure gli altri capirono.
Il pastore disse: «Per me, la giustizia è un pretesto dei ricchi per mantenere gli sfruttati al loro posto. Sempre, l'ho sperimentato.»
«Non è giustizia, quella…» mormorò il minatore, «la giustizia è di tutti e per tutti.»
Il contadino rifletté e disse con umiltà: «Ho vissuto una vita e non ho imparato a vivere.»
«Non ti crucciare, Orrù Gavino,» si affrettò a confortarlo il minatore. «Credi tu che ci sia uomo, anche di cent'anni, che sappia perché ride e perché piange? Se lo sapesse… potrebbe dirlo a tutti. Lo direbbe alla gente appena nata. Così la vita sarebbe come una bella favola. Tutti vivrebbero felici e contenti. Ma è una bella favola la vita?»
«Come?!» Intervenne il pastore perplesso, «sono davvero tutti uguali, gli uomini?»
«Credi tu, forse, che la tua vita sia diversa dalla mia?» rispose l'altro con amara ironia.
«E' ciò che vorrei sapere,» disse il pastore. «Potete ascoltare, se avete lo stomaco forte.»
Sedettero di nuovo, rasserenati - contenti di non essere soli.
La corriera aveva rallentato la corsa, cominciando ad arrampicarsi sopra un monte di pietra. Nella poca terra imprigionata nelle conche fiorivano asfodeli. Qualche rara elce scarmigliata dal vento, curva al sole del mattino, piangeva su tombe di granito. E pecore in processione andavano col muso per terra, fiutando nella brezza la speranza di un mentastro. E cani ossuti, attorno. E pastori col mantello nero sul capo fino ai gambali, fucile a spalla, immobili sopra speroni di roccia, sull'uscio degli anfratti, davanti alle braci dei fuochi notturni.
S'era fermata in un paese coi muri di pietra squadrata. La strada lastricata saliva tortuosa, terminando sopra un terrapieno. Oltre la ringhiera nereggiava l'abisso.
Seduto sopra un masso conficcato sull'orlo del terrapieno attendeva un uomo vestito di velluto. La corriera gli si era fermata davanti con uno stridore di freni. Il motore aveva preso a ronfare e l'uomo ne aveva ricevuto sul volto l'alito caldo. Era salito dicendo: «Salute!» e si era diretto verso il fondo. Si era seduto come siedono tutti i pastori nomadi sul sasso incontrato lungo il cammino: curvo e teso, baculo fra mani e ginocchia, guatando con occhi socchiusi l'immobilità e il silenzio del deserto, lo scorrere lento del tempo e delle nuvole.
La strada risaliva in un aspro serpeggiare di tornanti - da un lato sovrastavano guglie di granito simili a filari di cipressi pietrificati… Un sapore di eterno, la vita; un senso assurdo, la vita. Soltanto uomini e pietre che si calcificano nel tempo e si sgretolano nel tempo, per dare un velo di terra alle piane e alle conche a valle - perché la roccia diventi terra e germogli l'esile verde per le greggi affamate.
Il pastore aveva rivisto i fanciulli tornare a sera con trofei di lucertole e di passeri implumi… il giorno che aveva calzato i primi gambali, vinta la paura del sasso scagliato e del sangue, e la fierezza del moschetto imbracciato… il sussurro delle donne che in crocchio filano e tessono la lana bianca e nera, come il destino tesse il bene e il male delle creature nate sulla pietra… La sua donna non aveva più lana da tessere, ed egli sapeva di essere un uomo senza destino.
«Io sono Coccoi Sebastiano, classe 1917, figlio della Grande Guerra. Per dire tutta la vita basterebbe dire un giorno. Ogni giorno è uguale preciso agli altri. Ma forse è sbagliato parlare di giorni. Il pastore non conosce giorno, né notte. Dorme quando può, con un occhio sempre aperto, perché il mestiere suo è di stare attento. A destra e a manca con le pecore. Le terre in affitto, una a ponente e una a levante. Pensavo, che per pensare tempo ne ho sempre avuto - così avessi avuto pascoli! Però stanca e rattrista il pensare, pensare da solo - anche se non è fatica come zappare… La famiglia che mi ha cresciuto era di pastori, ed io ho fatto il pastore da piccolo. Ero figlio di nessuno e di tutti. Chi mi voleva mi prendeva - a pascolare pecore, capre e maiali. Chi non mi voleva mi lasciava. Appena mi è spuntata la barba ho calzato i gambali e ho imparato a saltare muri e crepacci, a correre e a strisciare silenzioso nei macchioni, con le mani legate… So leggere e scrivere non perché sono andato a scuola, ma perché ho fatto il militare. Certo non è una cosa buona fare il militare come l'ho fatto io: sette anni e otto mesi. Non mi hanno dato sussidio, né pensione. Avevo vent'anni, quando fui richiamato. Giorno di festa mi pareva quel giorno! in giro per il paese a bere e a fare baldoria. Fui tradito dopo il periodo di ferma, quando c'era la guerra. In caserma fu esposto un manifesto: "Chi voleva andare nell'Autocentro del 4° Reggimento Fanteria per imparare il meccanico." Io feci domanda e mi presero. Mi caricarono con altri su una nave e ci sbarcarono sopra un monte. Mi trovai sbandato, per l'ambiente e per il freddo. A chi portava baffi gli gelava l'acqua sopra, quando andava a lavarsi di mattina. Dopo qualche giorno ci inquadrarono con altri nuovi e ci mandarono al fronte. Il18 febbraio del 1941 arrivai al fronte di Calivaci - in Grecia, mi dissero. Ma il nemico, che non conoscevo, nessuno mi disse dov'era. Appena fattosi giorno, tutti andavano in giro come pecore matte, quand'ecco la mitraglia ci sfiorò un paio di raffiche che troncarono le gambe ad uno. Così capii dov'era il nemico. Il mio caporale, di nome Piras Giuseppe, era un bravo compagno. Non dormiva per niente, fino a quando non riusciva a portarci il rancio; e noi in comune stavamo al reticolato. Il 16 maggio compiva l'anno che era morto un mio amico gavoese ucciso a tradimento da una pattuglia di carabinieri. La notte lo ebbi in visione. Mi saltò il dubbio di non dormire, perché il giorno dopo sarebbe stata una triste giornata. Di fatti, dopo mezzogiorno, le nostre artiglierie accorciarono il tiro e ci presero in pieno nelle tende. Fu un macello, ma io nessuna ferita. Venne l'ordine di disfare la posizione e incominciò l'avanzata. Poi l'armistizio. Allora si tornò indietro per molti giorni e rimanemmo accampati ad una decina di chilometri da Coriz, dove mi ammalai di tifo. Fui ricoverato nel 78° ospedale da campo. Il medico che mi visitò non si persuadeva della mia malattia. Ma con l'intervento di un altro medico fui salvo. Rimasi aggregato alla 7ª Compagnia del 38° Reggimento, presso il prelevamento viveri e trasferito alle Termopoli, precisamente al ponte Brallus. Ci rimasi circa sei mesi, pescando carpe e facendo conoscenza coi partigiani. Appena spostati noi del 38°, i partigiani fecero saltare il ponte. Allora ebbi modo di conoscere la fine di Mussolini, che io non avrei mai creduto, e seppi che c'era una società che lavorava per il futuro. Il 13 settembre 1943 fui disarmato a Lamia; da lì portato in Germania, al campo 12D e con il lavoro obbligatorio capii che l'uomo è al di sotto della formica. Pensavo ai malvagi della terra, al perché di tanto egoismo nell'umanità… Sono tornato nel mio monte, nudo e pieno di ferite. Con la guerra ho visto che ci sono tanti uomini… ma dove ci sono pietre, restano solo pietre e pastori come me e pecore come le mie. Ho visto piazze grandi piene di gente e di luci; ho visto palazzi di marmi e ferrovie e ponti… ma dove ci sono pietre restano solo pietre e pastori come me e pecore come le mie. Spietrando campi a valle mi sono rifatto un gregge di quaranta capi. Se ne è andato presto il fumo, ché mi è nata una figlia malata. Cinque anni all'ospedale… Coi soldi prestati dai mercanti mi sono rifatto due dozzine di pecore. Ma costano cari i pascoli! Con due ettari, l'incasso non paga il fitto. Se uno è onesto, o muore o crepa. Se no,va con quelli di Sedilo a fare bardana. L'egoismo è ciò che guasta tutto. Quando vedono che cerchi di mangiare la pagnotta… zac! te la levano di bocca. A questo ho pensato ogni giorno. E mi sono stancato di pensare sempre la stessa cosa. La storia del pastore è come la storia degli antichi ebrei: sempre girando nel deserto, morti di fame, cercando la terra promessa in mezzo ai nemici, cercando la pace… Ma ai pastori come me, nessuno ha promesso terra, nessuno ha mai fatto piovere manna sulle pietre… Avevo un pacco da portare a mia figlia, all'ospedale, quando la corriera…»
«Ma allora… è così,» mormorò il contadino quando Coccoi Sebastiano finì di parlare.
«Così come?» chiese ansiosamente il pastore.
«Niente,» rispose l'altro, e riabbassò il capo come gli altri, per riflettere, ciondolando gli scarponi nel vuoto.
«Così come, Orrù Gavino?» ripeté il pastore dopo lungo silenzio.
«Credo di aver capito perché tu ed io facciamo la stessa strada. Se è come penso…»
«Pensi che siamo due miserabili, io e tu. E' così?»
Il contadino non rispose. Fissò lo sguardo lontano dove si profilava l'arco verde che pareva un colle. «Sapete,» mormorò «L'ulivo della vigna quest'anno darà i primi frutti.»
Il minatore si scosse. Disse: «Siamo troppo attaccati alla terra. Se continuiamo così non arriveremo mai.»
Il pescatore lo guardò con sospetto: «Perché tutta questa fretta di arrivare?»
«Prima arriviamo, prima riposiamo,» rispose l'altro.
«Riposare? E che ne sai tu? Non vorrai farci credere che tu hai già fatto questa strada…» replicò ironico il pescatore.
Gli altri acuirono l'attenzione.
«E come potrei averla già fatta? L'ho immaginata, però. Si può capire, no?»
«No, non lo capisco,» disse il pescatore smettendo il sorriso ironico, «spiegati meglio.»
«Siamo ancora attaccati alla terra con le radici del nostro cuore. Questo volevo dire. La strada sarà tanto lunga quanto tenaci saranno queste radici… Forse non arriveremo mai, se non ci dimenticheremo.»
Il volto di ognuno ripeté lo sforzo di penetrare il concetto. Il pastore ruppe il silenzio per primo: «Forse è così. Ma tu, dimmi, vuoi tu arrivare e dimenticare la vita?»
«Non lo so bene, ora. Forse non dovremmo parlare più di ciò che siamo stati. E' come gettare un'altra radice verde in questo cielo di azzurro.»
«Sì,» disse il pescatore, «forse è meglio riprendere il viaggio senza voltarci indietro, senza pensare, senza parlare più.» Si levò in piedi ed esclamò: «Forza, si parte! Minatore, tu che sei così saputo, facci strada.»
Si guardarono e sorrisero. Il minatore si avviò per primo, segnando il passo. Gli altri gli tennero dietro.
Camminarono a lungo, senza parole, con gli occhi pieni di azzurro, assopendo il tumulto dei ricordi nell'infinita quiete dello spazio.
Il nastro grigio riprendeva a salire. L'arco verde diventava sempre più breve e sfumato nell'orizzonte. Il contadino - che non aveva occhi se non per quella parvenza di colle - se ne stupì e se ne addolorò. Stupore e dolore gli si trasformarono in rabbia. Gettò per terra il cesto e corse avanti ai compagni, si voltò poi contro di loro agitando le braccia, gridando: «Basta. Non ne posso più, non ne posso. Io non mi muovo, da qui! Non mi muovo neppure con tutta la giustizia! Non m'importa nulla di questa strada, di dove va o di dove non va… Io da qui non mi muovo! Voi andate dove vi pare…» si lasciò cadere per terra accoccolandosi con le braccia sulle ginocchia.
Gli altri gli si fecero attorno, turbati.
«Guarda, Orrù Gavino, guarda…» sussurrò il minatore, indicando un punto all'orizzonte.
Il contadino non si mosse.
«Guarda, Orrù Gavino, guarda il tuo colle…» ripeté il minatore, chinandosi su di lui, parlando con voce dolce.
Il contadino levò la faccia lacrimosa e guardò. L'arco verde si era fatto più largo e più nitido. La strada grigia scendeva in un dolce ondare di tornanti.
«Hai gettato una nuova radice, Orrù Gavino. Se è questo che tu vuoi, continuiamo a parlare…»
«Io… una cosa sola, vorrei…» singhiozzò il contadino, «vorrei vedere il mio ulivo. Deve essere in fiore, adesso…»
Sedettero ancora, per la terza volta, lasciando tumultuare il mare dei loro ricordi.
Il contadino mormorò: «Glielo avranno già detto, in casa?»
Il pescatore si irritò. Disse: «Orrù Gavino, tu sei il peggiore mangiavermi che ho mai conosciuto. Sei una lagna… neppure gli sparlotti del golfo sono come te!»
«Proprio così!» Rincalzò il pastore, iroso, «sei uno sporco maurredino, che pensa solo a se stesso… E noi! siamo bestie, noi?»
«E' più sincero…» intervenne il minatore, «anche noi, certamente, abbiamo pensato come lui, ma noi ci siamo vergognati di essere sinceri, per apparire forti.»
«Io, anche se non ho famiglia, ho compagni…» brontolò il pescatore.
«Come, non hai famiglia? E perché non hai famiglia? Tutti hanno famiglia. E tu, perché no?» Gli chiesero.
Il pescatore si rattristò. Disse: «Un uomo può essere povero, tanto povero che non può neppure guardarla una donna. E allora guarda gli altri poveri come lui, e diventano la sua famiglia.»
Lo guardarono commossi. Il minatore gli si fece più vicino; pronunciando le parole con lentezza, disse: «E' arrivato il momento di dire chi sei.»
Accanto all'arco verde del colle si andavano formando macchie di nubi biancastre, simili ad un gregge di pecore meriggianti.
Superato l'ultimo dosso, la corriera si era affacciata sulla pianura. Una tavolozza giallo-stoppa macchiata dal rosso sbiadito dei tetti dei villaggi, dal verde intenso degli ulivi, dal grigio plumbeo delle paludi disseminate a lato del golfo ancora avvolto nella foschia del mattino.
Aveva accelerato la marcia, rombando a velocità costante sul rettifilo gettato come diga sugli acquitrini densi di falasco.
Era entrata in un paese dalle case basse di fango distese al sole, popolato di gente scalza e sonnolenta. Aveva attraversato un piazzale vasto erboso tra stagno e chiesa - c'erano vecchi rattrappiti dai reumi, seduti per terra nel lato riparato dal maestrale, curvi a ruminare antichi assilli, in attesa del primo sole. Frotte di donne dalle gonne ampie lunghe andavano e venivano, trascinando polvere e stanchezza. Innumerevoli bambini laceri, gonfi, vociavano giochi violenti - rotolandosi per terra, lanciandosi canne appuntite e sassi, rincorrendosi, assalendosi l'un l'altro come nemici.
Le case intorno al piazzale erano bettole - già affollate di uomini senza berretto e senza scarpe. La corriera si era fermata davanti ad una delle bettole. Sulla soglia sedeva un pescatore. L'uomo aveva sorriso senza un perché; si era levato stancamente, era salito esclamando ilare: «Bella giornata, oggi!» e aveva preso posto davanti, per vedere la strada.
Era ripartita con una turba di ragazzini urlanti dietro. Aveva lasciato le ultime case cinte di letamai, dove altri ragazzi e cani vagavano rovistando. Aveva costeggiato per lungo tratto una distesa acquitrinosa, lussureggiante di inutile vegetazione, solcata da viottoli sabbiosi, serpeggianti tra falaschi e giunchi. Aveva incontrato uomini con la sporta dei pesci a spalla o appesa al capo, e uomini con la fiocina e il corbello della palamite.
Il pescatore si era portato con lo sguardo oltre il mare d'erba, dove lucevano le chiazze irregolari delle paludi… Il tepore dell'acqua densa e l'umidore pesante avvolge il corpo come una carezza… il silenzio rotto a tratti dal gracidare vicino e lontano e dal cauto sciaguattare dei piedi… il picchetto di canna sormontato dallo straccio nero legato a un capo della palamite e l'impercettibile filare degli ami… ai margini della palude, la sagoma triangolare della baracca delle guardie… trecento metri di ansia - tanto quanto lunga la funicella - e l'attesa - l'accoccolarsi sulle calcagna infisse nella melma, con le reni arcuate nell'acqua… Al largo, sui fondali aperti e fondi, i barchini padronali, in agguato… i fruscii dei canneti - forse soltanto un improvviso soffio di vento venuto dall'infido mare - e la paura… una creatura buona, la palude, che dà ogni suo frutto dolcemente a chiunque glielo chieda… basta tendere la mano, per avere… ma popolato di nemici, guardie armate di cani e di leggi impietose… galera e reumi da far marcire le ossa…
Il pescatore si era scosso ad un sussulto della corriera, che uscita dalla piana saliva verso una barriera montuosa. Egli aveva fermato l'attenzione sull'insolito paesaggio. Creste rocciose color d'indaco si stagliavano nel cielo sbiadito. Aveva osservato le frastagliature che si dilatavano e si contraevano assumendo forme diverse, nelle quali scopriva, di volta in volta, figure umane e animali del suo mondo palustre.
«Io sono Atzori Giosué, di 46 anni, senza famiglia, pescatore abusivo. Senza barca, senza reti e senza acqua - perché paludi pesci attrezzi sono del padrone che ha guardie armate e la legge. C'è però il succo dell'euforbia, che non costa nulla. Se ne raccolgono le radici, si pestano con un sasso e si gettano dove l'acqua è ferma. I pesci ubriachi si lasciano prendere con le mani. Ci sono bombe anche, che non costano nulla - dopo la guerra ne sono rimaste tante che bastano a far crepare tutti i pesci del mare. Un affare rischioso però, disinnescare bombe ed aprire bossoli. Mio padre anche lui c'è rimasto, sbrindellato come uno straccio tra i denti di un mastino. Picchiava con un sasso. Una disgrazia - hanno detto. Cose che possono succedere nel mestiere… Oppure, con poche lire, uno si può fare una palamite, spago e ami. I vermi anche, non costano nulla. Basta frugare la terra con una zappa, e in mezza giornata se ne trovano da riempire un barattolo. Ci ho perso la vista, ad escare ami di palamite seduto in riva alla palude, col sole del tramonto. Ci ho perso le ossa, dentro l'acqua fino alle reni salpando palamite. Ci ho perso la testa, per paura delle guardie del padrone - se ti scoprono ti prendono pesci e attrezzi e in cambio ti danno qualche anno di galera. Quando va bene, il pranzo si fa. E' stato nel 1946, quando sono ritornato dalla guerra, che ho cominciato a pensare con la mia testa. Ormai i fascisti non comandavano più… così credevo! Sono andato in Municipio, per vedere come stavano le cose, per chiedere un lavoro. Non mi hanno neppure ascoltato. Hanno detto di levarmi dai piedi. Il sangue mi è salito alla testa. Ho detto che avevo fatto la guerra, io, sacrificato la mia vita, io, mentre loro erano rimasti al caldo, succhiando il sangue della povera gente. Sono arrivati i carabinieri, e come succede sempre si sono messi contro il povero. Mi hanno afferrato per portarmi via come un delinquente. Glielo ho detto che ero un reduce, che volevo solo lavorare per mangiare. Ma loro niente. Allora mi sono liberato con uno strattone. Li ho stesi per terra tutti e due, e sono fuggito. Fuggito per niente, però. Due anni giusti di galera, uno per ogni spinta. Così è nata l'idea di liberare le acque delle paludi. L'idea che da quei giorni di galera ho portato dentro di me ogni ora e ogni minuto della mia vita… Quand'ero ragazzo, no, non ci pensavo. Ero più stupido di una bestia. A scuola no mi mandavano, perché non sta bene ai poveri studiare. I poveri devono lavorare. Lo diceva sempre mio padre: "Non ti sta a te andare a scuola." Però in chiesa sì, mi ci mandava! Non mi faceva perdere una messa. Anche a pugni e a calci, se la voglia mia non c'era. Dopo è uscita una legge che dice ai padroni di lasciare libere le acque che Dio ha fatto piovere su tutti gli uomini. Allora sono andato in giro per il paese e per le campagne, a dire che era arrivato finalmente il nostro giorno. Molti ridevano e mi prendevano per matto: i padroni restano sempre padroni, perché le leggi se le fanno e se le disfano loro come vogliono. Il giorno più bello della mia vita è stato il giorno in cui ci siamo riuniti e abbiamo pescato tutti insieme, proprio in mezzo alla palude, alla luce del sole, davanti a tutto il popolo accorso sulla riva. C'erano più carabinieri che pesci, quel giorno. Ci hanno arrestato tutti quanti. E noi, appena fuori di prigione, di nuovo a pescare. Il padrone e i carabinieri ci dicevano: "Voi entrate a pescare e noi vi rimettiamo in galera. "Un giorno di pesca, tre mesi di galera. Così è andata avanti la mia vita… Perché andavo a Cagliari? Per dire alla giustizia di preparare una prigione fissa…»
«Ma che razza di giustizia!» Sbottò il pastore appena il pescatore finì di parlare. «E palle di fucile non ne avevate? E che razza di gente è quella delle parti tue, se…»
Il pescatore chinò il capo.
Il contadino intervenne: «Dici bene, tu, Coccoi Sebastiano, che non avevi il piede sul collo…»
«Un uomo non si lascia mai mettere il piede sul collo, se è un uomo,» replicò il pastore, aspro.
Gli altri due rivolsero lo sguardo al minatore. Ma questi non parlò, assorto nei propri pensieri.
«Pensi sempre, tu?» Lo scosse uno, ponendogli una mano sulla spalla.
«Scusatemi. Ascolto,» rispose.
«E allora, che ne dici, tu, di gente come Atzori Giosué, che si lascia portare innocente in galera, senza neanche dire bah…»
Il minatore non rispose.
«Credi anche tu?…» gli si volse il pescatore, angosciato, «anche tu, di', credi che sia una festa, la galera?»
«E perché ti ci lasci chiudere allora, Atzori Giosué?» rincalzò il pastore - il suo volto pareva assaporare il vento aspro delle gole e gli aromi vischiosi ed acri del suo monte.
«Tu avevi monti e boschi, Coccoi Sebastiano,» mormorò triste il pescatore, «tu avevi ali e cielo per volare. L'uomo delle paludi è nudo come un verme sulla terra piatta.»
Il minatore parlò, allora. Disse: «Atzori Giosué, io credo e so che il coraggio di patire la galera è grande quanto il coraggio di chi si chiude da se stesso nella solitudine di un monte.»
I compagni rimasero a guardarlo, in attesa di altre parole.
«Parla ancora,» lo pregò uno, «tu dici parole che da sempre desideravo sentire.»
Il minatore sorrise senza compiacimento. Disse: «Se tu desideri ascoltarle, sono parole anche tue. Ogni uomo può dire parole per tutti. Io so che abbiamo tutti parole così, parole per tutti. E anche una strada, grande per tutti deve esserci. Come questa, uguale per tutti…»
Riandando con lo sguardo sul nastro grigio che si snodava nell'azzurro, in lieve pendio. Fermarono l'attenzione sul colle, nitido di macchie verde chiaro come i pampini nuovi della vite. Più in là si intravvedeva una massa scura avvolta da nubi sfilacciate.
«Dietro quelle nubi - ma sono nubi? - c'è qualcosa che rassomiglia a un piano…» mormorò il pescatore.
«E nel piano, le tue paludi,» aggiunse il minatore, «te le sogni, Atozri Giosué, le tue paludi…»
Disse il pastore: «Che domanda! Anche la galera ha patito, per le sue paludi. Non l'abbiamo capito, forse?»
L'altro ebbe una luce di gioia negli occhi. Disse: «Certo, Coccoi Sebastiano. Ora l'abbiamo capito. Ora possiamo riprendere il nostro cammino con cuore più leggero.»
Si levarono in piedi e si sgranchirono, respirando profondamente, socchiudendo gli occhi con voluttà.
«Sapete,» confessò il contadino, «che non ho più paura? Insieme a voi, neppure del diavolo ho paura… E dire che volevo cercare un'altra strada, da solo…»
«Questa è la nostra forza, Orrù Gavino: fare insieme la stessa strada,» disse il minatore.
«Perché non capirlo prima? Capirlo tutti insieme?» Mormorò il pescatore, pensando alla gente delle sue paludi.
«Non ti crucciare, adesso, Atzori Giosué: cantiamo,» propose il pastore, avviandosi, «mi è venuta voglia di cantare. E se non mi burlate vi dico una cosa… Sento odore di frattaglie arrosto e di rosmarino venire dal mio monte. Se aguzzo le orecchie odo il belare del gregge e il tintinnio dei campanacci…»
Si presero a braccetto e intonarono un canto, avanzando quasi a passo di danza.
Orrù Gavino fu il primo a fermarsi. Disse: «Ho il presentimento che il mio viaggio stia per concludersi.» E il suo viso divenne più intenso, più umano. «Ma prima vorrei almeno sapere il tuo nome,» aggiunse, rivolgendosi al minatore.
«Io sono come te, Orrù Gavino, come voi,» disse il minatore.
«Lo so. Credo di averlo capito, adesso. Ma tu, sembri più infelice, più buono…»
Il minatore tacque per un po', confuso. Sedette sull'orlo della strada. Gli altri gli si accostarono, restando accoccolati.
«Non dire così,» si schermì il minatore, «non giudicare mai l'uomo, Orrù Gavino. Non c'è buono o cattivo Dove c'è l'uomo c'è soltanto l'uomo.»
Il pescatore annuì. Disse: «Se gli uomini fossero chi buono e chi cattivo, allora sarebbe giusto condannare e uccidere, segregare e umiliare. Anche la guerra, anche la fame sarebbero giuste.»
Il contadino disse: «Ma tu, minatore, perché hai capito prima degli altri? Hai fatto molta scuola, tu?»
«Scuola? Non c'erano banchi, né maestro nella mia scuola.»
I compagni si stupirono. «Una scuola senza banchi e senza maestro?»
«E' così. Vi dirò anch'io la mia vita.»
«Alla buon'ora!» Esclamò il pescatore, «già me l'avevano detto che sono chiusi quelli della tua razza…»
«L'uomo non può parlare con la bocca piena di terra,» mormorò l'altro.
«Sì, ma adesso esci dal buco e parla,» lo esortò scherzoso il pastore.
Erano monti recenti su monti antichi - i più nudi, i più desolati. Cumuli di ghiaie squamose ostruivano le vallate. Radi lentischi sopravvivevano su brevi terrapieni, al riparo di casupole di schisto, isolate senza sentieri.
La corriera aveva attraversato cantieri, baraccamenti, laverie, sottopassaggi - agglomerati deserti, senza campagne e senza frutti. Un mondo dove la gente vive sottoterra.
Un uomo sul ciglio della strada aveva fatto un cenno con la mano. Il mezzo si era fermato ed egli era salito, sedendosi senza badare dove. Un uomo amaro e schivo - come tutti gli uomini che scavano pietre nere, come chi deve guardare dentro di sé per trovare sole e prati, stelle e boschi.
La corriera aveva costeggiato una laveria abbandonata. I carrelli pendevano immobili imprigionati dalla ruggine nel cavo della teleferica. Travi rotte scheggiate infisse nei detriti squamosi; enormi braccia di macchine semisepolte sul costone della discarica; frantoi e vasche di cemento senza pietre da frantumare, senza turbini d'acqua da sceverare: un corpo di gigante smembrato, sparso in un deserto senza sole e senza vermi.
Partiva un viottolo dalla laveria abbandonata fino al mare. Serpeggiava in fondo a una gola, fra montagne di pietrisco - le interiora velenose che appestavano e corrompevano ogni forma di vita. Parallelo al viottolo, di poco più basso, come un serpente grigio dalle reni spezzate, giaceva un fiume di limo denso immoto Una polvere assurda che nessuna corrente d'acqua riusciva a trascinare, che usciva dall'alveo come nebbia - col vento - ricoprendo di una morte lenta inesorabile alberi e cervelli ed erbe. Alla fine del loro corso le acque grevi stagnavano formando una macchia larga cupa - una ferita mostruosa - nel verde limpido del mare.
Non volavano uccelli su quel mondo. Non stormivano fronde, né belavano pecore, né voci sussurravano… Il minatore aveva rivisto i sedici anni biondi, perduti lungo il viottolo dalla laveria al mare… Portava la giacca della domenica ed un fagotto sulla spalla - portava fame e speranza, nostalgia di mandorli in fiore e di verdi siepi. Era il più giovane della squadra. I compagni lo tenevano indietro, nei cunicoli senza armatura - così nessuno aveva mai veduto le sue lacrime. Il primo maggio era festa grande. Le mimose gialle fiorivano a grappoli sulle acacie - e le speranze verdi, nei cuori. Si festeggiava in cima al colle. Comizio e gente, torroni e bandiere, sorbetti e fisarmonica. L'imbrunire era il momento più umano di un giorno di magia. Dai pali pendevano le lampade ad acetilene. La penombra addolciva ogni angoscia. La ricordava tra la folla. Un sorriso e un gesto d'intesa. Egli aveva un grappolo di mimosa all'occhiello della giacca, e lei un mazzetto fra i capelli e tracce di polline sulle guance. Gli aveva preso la mano scuotendo indietro i capelli lunghi lisci, avviandosi per il sentiero aperto tra gli ulivi… L'aveva rivista con altro volto, con la polvere bianca del tempo sui capelli lunghi lisci, con lo scialle nero del lutto… Non c'era più sentiero aperto tra gli ulivi… Tra cumuli di ghiaie sterili, come un serpente bruno dalle reni spezzate, giaceva il fiume dalla laveria al mare.
La corriera non aveva altre fermate fino alla città. Aveva imboccato la strada nuova listata di bianco. Aveva accelerato al massimo attraverso la pianura.
C'era il sole già alto - le prime ciminiere col pennacchio fuligginoso e i tralicci argentei sul dorso del colle di San Michele e l'arco del golfo degli Angeli. E c'era sulla strada una scheggia di ferro che trinciò il copertone di una ruota. Il mezzo aveva sbandato, si era impennato, si era capovolto mordendo strappando l'asfalto. S'era schiantato nella cunetta, incendiandosi.
«Sono Floris Efisio, di 36 anni, minatore da venti anni. Mio padre era accacigadori. Lavorava più spesso in casa dei clienti - la gente non si fida se non vede con i propri occhi. Alle due del mattino andava al lavoro con la vasca di legno a spalle. Qualche volta - bambino - lo seguivo; attizzavo il fuoco sotto il calderone dell'acqua e guadagnavo il cibo per tutta la giornata. Badavo che l'acqua non fosse troppo calda, né troppo fredda. Mio padre stendeva sul fondo della vasca il telo di orbace tessuto di recente e lo ricopriva di acqua tiepida. Allora si levava le scarpe, vi riponeva le pezze da piedi, ed entrava nella vasca, cominciando a pestare e a stropicciare la stoffa. L'orbace è ruvido, ed erano necessarie molte ore di ininterrotto calpestio prima di renderlo morbido e fitto. Di tanto in tanto sprimacciava il tessuto con le mani e lo tendeva. Lo schiocco faceva contenta la padrona, che gironzolava intorno ficcando le dita nell'acqua ad ogni minuto per controllare la temperatura. Mio padre si interrompeva soltanto una volta per mangiare una fetta di pane e il comparatico, poi ricominciava da capo il suo trapestio ritmico che pareva una danza - le mani appoggiate ai bordi della vasca - fino al tramonto e spesso oltre, a lume di acetilene. Era la padrona che giudicava finito il lavoro - palpando quanto morbido e fitto fosse il tessuto. Riceveva la mercede in grano, si rimetteva la vasca sulle spalle e rincasava… Io ero il settimo di dieci figli. A cinque anni andavo a portare la minestra a mio padre, quando non c'era orbace tessuto di fresco e il grano della campagna aveva bisogno di zappa. Egli mi dava mazzi di asparagi e cappellate di lumache da portare a casa… La campagna del mio paese è meravigliosa. I mandorli e il biancospino e il pruno fioriscono a febbraio, appena il cielo si fa azzurro tiepido. E a scuola non ci andavo volentieri, pensando ai nidi sugli alberi, alle lucertole tra i sassi, alle more delle siepi. Non mi piaceva e il maestro, con una scusa o con un'altra, mi dava ogni giorno una lezione di bacchetta. Forse aveva ragione lui, allora. Io non stavo mai attento. Così non ho mai imparato a leggere e a scrivere. Mi facevo picchiare subito appena arrivato, per essere lasciato tranquillo dopo. Appena entrato andavo difilato in cattedra. "Mi picchi - dicevo - anche oggi non ho fatto i compiti. "E niente compiti facevo in classe. Solo pensare che le uova nel nido della tortora forse si erano schiuse. Mi piaceva, qualche volta, ascoltare la storia, perché parlava di guerra. La guerra mi piaceva. Pensavo: "Da grande faccio la guerra." E non sapevo che già la stavo facendo tutti i giorni, la guerra contro la fame… Ma questo l'ho capito anni dopo, una sera che mia madre piangeva e mio padre mi chiamò e mi disse: "Efisio, tu lo vedi, ché sei già cresciuto. I figli sono molti e il pane è poco. Ti sei fatto grande, figlio mio, e devi badare a te stesso, ché io sangue da darti non ce n'ho più. Se resti qui, la croce già la conosci: zappare grano o pascolare pecore per tutta la vita. Se parti c'è la miniera. In dieci anni di sacrificio puoi mettere soldi da parte, come altri hanno fatto, e aprire una bottega o comprarti un mezzo…" A sedici anni sono entrato in miniera… un mondo dove l'uomo non ha occhi per vedere, né orecchie per sentire, né bocca per parlare. Non c'è sole, né stelle, né vento, né pioggia in quel mondo. Non c'è verde di prati, né olezzo di fiori, né siepi di biancospino… L'uomo non è più uomo se non è nel suo mondo. Il minatore è un verme che scava buchi sottoterra… Quando suona la campana sulla torre del pozzo, la gabbia scende e la terra si richiude sulla tua testa come una tomba. Hai paura di aprire la bocca perché non si riempia di terra. Tu sai che sei vivo. La senti che pulsa, la vita. Ma sai anche che non sei più un uomo. Sono otto ore giuste, sotto terra, ogni giorno. Quando la gabbia ti riporta su, le prime volte provi il gusto della vita che ritrovi, che riprende… il gusto di rivedere, di risentire, di riparlare. Poi, ogni giorno che passa, è sempre più difficile riprovare quel gusto. Quando non senti più il gusto della vita, né il desiderio di provare quel gusto, allora sei diventato minatore… Dopo venti anni c'è stata un'inchiesta sanitaria, nella mia miniera. Avevo i polmoni bruciati, e non lo sapevo. Ricovero d'urgenza. Tutto finito. Ogni sei mesi, una settimana di visita in famiglia. Stavo rientrando in sanatorio. Così ci siamo incontrati, voi ed io…»
I compagni finirono di ascoltare con animo turbato. Non trovavano alcun modo di dare conforto, se non tacendo.
Il pescatore fu il primo a parlare. Disse: «Ma soldi, Floris Efisio, soldi ne hai fatto con quel lavoro?»
«Certo, soldi,» intervenne il pastore, «uno mica fa un lavoro come quello, se non è per i soldi.»
Il contadino aggiunse: «E perché non te ne sei uscito subito da quel posto, appena hai fatto soldi? Ho sentito dire che si guadagna molto, più di cinquantamila, con quel lavoro…»
Il minatore scosse il capo. «I soldi… lo so. Anch'io, come tutti gli altri, sono entrato con la speranza di scavare soldi, non solo pietre nere. Ma i soldi li ha e restano al padrone della miniera. Con una mano te li dà e con l'altra te li riprende. Ti dà tutto ciò che ti serve per mantenerti in vita, la baracca, la branda, la legna per cuocere il rancio e per la stufa, il pane e l'acqua. Ti fa stare vivo per farti lavorare. Ti paga per farti lavorare e si fa pagare per tenerti in vita. I conti devono tornargli giusti.»
«Possibile?!» Esclamò il contadino, «ma allora è peggio della terra. Io respiravo almeno aria pulita.»
«In venti anni, qualcosa sì… mi sono fatto la casa. Ero fidanzato tanti anni…»
«E poi?» chiese uno.
«E poi, la malattia… che cosa volete… mettere al mondo dei disgraziati… Le ho detto: "Senti, mi sei uscita di testa. Io non sono il tipo tuo. Levati l'idea anche tu, e vai per la tua strada." - Lei si è fatta dura come pietra. Mi guardava con occhi senza lacrime. Ha detto: "Ma lo sai quanti anni ci vogliamo bene, lo sai da quanti anni aspetto." Ho risposto: "Lo so. Io non credo al destino. Però ci sono cose che l'uomo non può cambiare, quando sono già successe. Tu mi devi perdonare; questo sì vorrei da te. Tu sei ancora giovane, e uomini che ti vorranno bene non ti mancheranno…" L'ho rivista una volta, nell'ultima settimana di visita. Ci siamo solo guardati…»
Il pescatore si levò in piedi, allargò il petto, aprì le braccia, arcuò la schiena, si riaccoccolò poggiandosi sulle calcagna. Disse: «Bando alla malinconia, compagni! Parliamo di cose allegre… La sapete la storia di Saruis Antonio l'emigrato?»
«Racconta,» propose il pastore, «qualche volta il riso fa buon sangue.»
«L'ho sentita all'osteria da un amico appena tornato dal continente. Ma non so se sia tutto da ridere. Parla di Saruis Antonio, un ragazzo del mio paese, uno di quelli cresciuti dietro un branco di maiali, in giro per i letamai sparsi intorno alle ultime case, piccoletto, ispido e di poche parole. La gente diceva che Saruis Antonio era povero di spirito. Non si fidava neppure a dargli una zappa, per paura che rovinasse il grano. Le ragazze lo beffeggiavano. In piazza se ne stava ai margini dei crocchi, ad ascoltare le chiacchiere. Sentì così di gente che partiva in continente, a cercare lavoro buono e sicuro. Una sera, ritornando a casa, andò dalla madre e le disse: "Sono deciso, madre. Parto anch'io, come fanno gli altri. "La madre, che conosceva Saruis Antonio meglio di tutti, gli rispose piangendo: "Antonio, figlio mio caro, quel mondo non è fatto per te. Il tuo destino è qui, nel paese tuo, con la gente tua. "Saruis Antonio fu irremovibile. Pianse anche lui con la madre, ma partì. Coi soldi che aveva raggranellato con tutte le paghe del suo lavoro di porcaro, arrivò giusto a Milano. Girò per giorni e giorni, bussando ad ogni porta, mangiando le verdure e la frutta rovistate di sera nei bidoni fuori dai mercati. Niente lavoro. Sentì dire che c'era congiuntura sfavorevole. Neppure una scopa per pulire cessi. Una sera che vagava affamato alla periferia, tra case di bandone e campi colmi di immondezze, incontrò un altro come lui, che gli disse: "Vai più in basso, Saruis Antonio, vai a Roma, che lì troverai. Mi hanno detto che trovano tutti, in quel luogo. Forse troverai anche tu, Saruis Antonio. "E Saruis Antonio prese il treno per Roma, senza soldi. Per ciò si rinchiuse nel gabinetto, fino a quando non lo scoprì il controllore, che, alla prima stazione, lo gettò dal treno nelle mani di due poliziotti. I poliziotti non sapevano che cosa farsene di un uomo come Saruis Antonio, che aveva solo peli, stracci e puzza di pecora, addosso. E lo lasciarono andare. Così arrivò a piedi a Roma. Ma anche lì posto non ce n'era, per Saruis Antonio. Egli portava pazienza, e continuò a cercare e a sperare. Un giorno si ritrovò davanti al cancello aperto di un grande giardino. Il posto era strano, ma bello. C'erano gabbie, grotte e recinti con animali di ogni razza. Vide l'asino, il cinghiale e il cavallino della sua terra. Li riconobbe subito. Se ne rallegrò molto e pensò: "Qui, forse, c'è un posto anche per me. "E bussò alla prima porta che trovò. Due signori sedevano dietro un grande tavolo. Lo fecero entrare e sentirono ciò che voleva. Lo esaminarono con interesse, si guardarono, ammiccarono e dissero: "Sì, un posto ci sarebbe. Trentamila e un pasto al giorno. "Saruis Antonio toccò il cielo con un dito e disse: "Pronto!" E si gettò avanti per baciare la mano ai due signori. Ma i due signori si schermirono, benevoli, dicendo: "Non è il caso." E storsero anche la bocca, perché Saruis Antonio puzzava. Tempo dopo capitò in quel giardino una banda di emigrati che cercava lavoro e se ne andava a zonzo per passare il resto della sera. Si fermarono a guardare l'asino. Uno gli fece il verso, un altro un gesto sconcio. Videro il cinghiale e lo stuzzicarono con pietruzze, per farlo andare in bestia. "Si è riminchionito!" Osservarono delusi. E tirarono avanti. Da un lato, in un pertugio metà grotta e metà gabbia notarono una scimmia che faceva strani gesti per richiamare la loro attenzione. "Ce l'ha con noi, quella scimmia," disse uno, sghignazzando. Aveva ancora qualche nocciolina in tasca e gliela gettò, avvicinandosi. La scimmia gli fece un cenno di richiamo, saltellando, agitando le zampe pelose, strizzando gli occhietti neri. "Ce l'ha davvero con noi," ripeté lo stesso. Anche gli altri si avvicinarono alle sbarre. "Ssss…" fece la scimmia, "che sono Saruis Antonio. Se passate dalle parti mie, diteglielo a mamma che ho trovato posto e che sto bene, qui…"»
Il finale della storia li fece ridere, ma presto si rabbuiarono. Il pastore disse: «Poveraccio, quel Saruis Antonio.»
«E' una storia… Non crederai mica alle storie, tu,» lo canzonò il pescatore. Ma il tono della sua voce suonava falso.
«La vita nostra, anche se la giriamo in burla, non fa ridere lo stesso,» mormorò il contadino.
«Meglio ridere a denti stretti, per nascondere la rabbia,» concluse il pastore, cupo.
Si volsero al minatore, che non aveva detto una parola.
Egli capì e disse: «Saruis Antonio ha trovato una strada, almeno. Io so anche che ci sono uomini senza strada…»
«Cosa vuoi dire?» gli chiesero.
«Voglio dire che ho conosciuto uomini che sarebbero stati felici di poter essere come uno dei cani del padrone della miniera.»
«Uomini di merda!» Esclamò il pastore sputando per terra, «io mangerei le pietre del mio monte, piuttosto che raccattare un pezzo di pane da terra.»
Il contadino e il pescatore si sentirono frustrati da quelle parole dure.
Il minatore impallidì ed ebbe un moto d'ira. Trasse più volte il respiro, fino a che sentì dentro di sé solo tristezza. Allora parlò, e disse: «Coccoi Sebastiano, uomo di pietra, non giudicare l'uomo se non vuoi che l'uomo giudichi te. Sei nato libero, tu. Quanto è costata a te, la tua libertà? e quanto è costata ai padri che te l'hanno data? che ti hanno insegnato a difenderla? Tu sei orgoglioso perché sei nato libero, Coccoi Sebastiano… Ma ci sono uomini che non sanno - perché non hanno strade. E' colpa loro, Coccoi Sebastiano, se non hanno strade? Perché non li aiuti, tu, a farsi strada? L'hai mai fatto, tu, questo? L'hai almeno pensato, tu, questo?… Che ti serve sputare sull'uomo, se tu sputi sulla tua stessa faccia, Coccoi Sebastiano?»
Il pastore non reagì. Si volse agli altri due e disse: «Scusate. Non volevo offendere nessuno. Conosco solo le pecore e le pietre del mio monte, e il mio orgoglio…»
Rimasero assorti per lungo tempo, senza rivolgersi sguardo o parola.
Atzori Giosué, il pescatore, fu il primo a ritrovarsi l'animo sereno. In tono faceto, disse: «Compagni, vi racconto un'altra storia. Questa fa ridere davvero. Parla di frate…»
Risero tutti insieme, prima ancora di sentire. Risero, per non pensare più.
Camminarono fino a distinguere il colore di cui era vestito il colle.
Orrù Gavino si fermò a guardare il giallo dei grani maturi, il verde chiaro delle vigne recinte dal fico d’india, il bruno delle zolle smosse dall'aratro. Cercò fra le altre la sua vigna. La riconobbe, con l'ulivo piantato nel mezzo. La indicò ai compagni e disse: «Io sono arrivato.»
«Ne sei sicuro, Orrù Gavino?» chiese Floris Efisio, «è questo che tu vuoi, Orrù Gavino?»
«Sì,» rispose l'altro, senza esitare, «è questo che io voglio.»
Il pastore e il pescatore abbassarono il capo, commossi, stropicciandosi i piedi sulla strada.
«Ne sei davvero sicuro?» Ripeté il minatore, «rifletti ancora, Orrù Gavino. Forse più avanti troverai la strada di cui parlavi.»
«Voglio attendere il frutto del mio ulivo. Non lo vedete, voi, come è pieno di fiori?» Mormorò.
«Hai creduto nel buono e nel cattivo. Non vuoi più cercare la strada lastricata di fiori e bordata di canti?» Non c'era ironia, nell'insistenza del minatore; non c'era neppure ansia di sentire risposta. Egli sapeva già ciò che Orrù Gavino avrebbe risposto.
«C'è voluto questo viaggio insieme, per capire. Quando non si porta più il peso del bisogno, è più facile capire, trovare la strada… Abbiamo fatto insieme la strada giusta, se ci porta dove ognuno di noi desidera arrivare,» rispose il contadino.
Atzori Giosué pensò alle sue paludi, e si rattristò. Ebbe un dubbio. Domandò: «Anche dove voglio arrivare io? Sicuro sei?» E guardò angosciato i compagni, mantenendo più a lungo lo sguardo sul minatore. Questi, senza parlare, accennò alla strada che proseguiva piana, scomparendo in un ammasso di nebbie, quasi all'orizzonte.
Rispose Coccoi Sebastiano. Disse: «Io credo di sì. Fra quelle nuvole c'è il mio monte.»
«Devi aver fede,» disse il contadino rivolto al pescatore. «Io sono nato prima di te. Per questo, forse, sono arrivato prima di te. Arriverai anche tu, se avrai fede di arrivare.»
Il minatore si animò; ebbe una luce negli occhi. Come parlando a se stesso, sussurrò: «Comprendo meglio, ora, perché ami la poesia, Orrù Gavino. Come potevi non vedere, tu, lo spirito di un dio nel germogliare del tuo grano, nel fiorire della tua terra? Tu sei il fanciullo dell'uomo, tu sei la poesia e il canto dell'uomo. Tu puoi essere il più triste e il più felice.»
Il pescatore ascoltò teso, per capire. Poi disse: «Io so quello che voglio. Ma non comprendo che cosa sia la fede.»
«Capirai, quando saremo oltre…» rispose il minatore.
«Subito, vorrei capire,» insisté l'altro.
«Io posso dirti solo una cosa: faremo la strada insieme. Io sarò con te fino a quando non avrai capito e trovato ciò che vuoi.»
Il pescatore guardò il minatore con una tenerezza mai espressa prima, di cui si era sempre vergognato. Né si vergognò di desiderare di abbracciarlo. Lo fece, e pianse, con la faccia sulla sua spalla. Poi disse: «Ora, mi dirai che sono una donnicciola…»
«Solo gli uomini fanno così,» gli rispose l'altro, commosso.
Il pescatore si accoccolò, sedendosi sulle calcagna. Tracciò alcuni segni con le dita sulla polvere grigia della strada. Levò il capo, e disse: «Perché lo fai, Floris Efisio? Perché vuoi restare per ultimo e solo, tu?»
«Perché questa è la mia storia. Questo voglio, perché mi appartiene… Ma ora dobbiamo proseguire,» si rivolse al contadino, «Orrù Gavino! che tu possa vedere nel tuo colle ogni frutto desiderato dal tuo cuore.»
Il contadino sentì l'augurio giungergli da lontano, come eco. Si era già inoltrato nel viottolo fiancheggiato da siepi di fico d’india, a cui si intrecciavano rovi penduli di more. Si voltò. Vide i compagni scomparire con la strada grigia nella nebbia del ricordo. Ebbe paura di sentirsi solo. Desiderò di ritrovare se stesso senza paura. Allora non si volse più indietro. Si guardò attorno. Rivide forme, colori, tracce familiari e ne ebbe gioia. Prese a camminare spedito, con animo ilare.
«Ecco la mia vigna,» esclamò. E aprì il varco nella siepe, spostando il fascio di rovi secchi. Entrò, chiudendo accuratamente. Camminò lungo i filari, carezzando con mano leggera, con dita di sabbia, le foglie tenere dei pampini, fino all'ulivo.
«L'ulivo… è davvero in fiore. Quanti fiori, quanti! Bisognerà sostenere i rami con forconi,» mormorò.
Sedette ai piedi dell'albero. Si distese, socchiudendo gli occhi, sereno. Si era sempre sentito triste e solo, fra terra e cielo. Aveva sempre espresso i suoi pensieri al ritmo della zappa che rompe le zolle con tonfo sordo. I suoi pensieri erano le alluvioni e la siccità, la brina e la filossera, il freddo e la fame, l'incertezza e la speranza, il silenzio e la solitudine.
«Aspetterò qui,» si disse senza voce, «avevo compagni, e non lo sapevo. Avevo strade e non le conoscevo.»
Sentì un canto levarsi, e non se ne stupì. Il canto era nella sua vigna; era nelle verdi siepi del fico d’india - gialle di fiori e nere di more; era nei ceppi scuri delle viti e nei pampini ondeggianti alla brezza; era nelle foglie d'argento del suo ulivo e nel suo cuore.
«Non mi fermerò più finché non sarò ai piedi del monte,» si propose il pastore.
I compagni faticavano a tenergli dietro.
Tra le nebbie si intravvedevano creste color d'indaco.
«E chi ti dice che tra quelle nebbie ci sia proprio il tuo monte, Coccoi Sebastiano?» gli disse il pescatore, per invogliarlo a parlare e moderare il passo.
Il pastore strizzò un occhio, furbesco. Disse: «Tu non sei pastore, non puoi capire. Io sento e fiuto meglio di un cane. Sento ciò che tu non senti e fiuto ciò che tu non fiuti… Odo belare di greggi e stormire di fronde. Fiuto olezzo di mentastro e di giuncata. Se chiudessi gli occhi, non sbaglierei un passo.»
«Sfido io…» borbottò il pescatore, «a rimuginare silenzio e pietre da secoli… Molte cose ho capito, in questo viaggio.»
«Anch'io. Ma una cosa, ancora non riesco a capire. Perché ci siamo incontrati così?»
«Già. Perché ci siamo incontrati proprio così?»
Non sapevano rispondersi. Si voltarono e guardarono il minatore, che camminava dietro a loro meditabondo. «Hai sentito, Floris Efisio? Lo sai, tu, perché ci siamo incontrati così?»
«Non me lo sono chiesto, il perché. Speravo, perciò sapevo che ci saremmo incontrati un giorno.»
«Ma non ti chiedi perché? perché così?… Somigli a Orrù Gavino. Solo che lui piangeva e tu no,» disse il pastore, rude.
«Forse è così…»
«Va bene. Però questo non spiega perché ci siamo incontrati così. Tu stesso hai detto che ogni cosa ha almeno un perché. Perché ci siamo incontrati così, Floris Efisio?»
«Se tu domandi, tu stesso devi risponderti,» mormorò il minatore incupendosi, «Forse la mia risposta è soltanto per me…»
Il pastore si irritò. Disse: «Perché, soltanto per te? La tua risposta può essere anche la mia e di Atzori Giosué. Se è così, io e Atzori Giosué ti diciamo grazie perché ci hai messo un pezzo di pane in bocca Se invece quel pane non è per i nostri denti, ti diciamo grazie lo stesso.»
«Scusatemi. E' vero, sì. Ma io so che è meglio se ogni uomo ha pronta la risposta sua, insieme a quella degli altri.»
«Sei un po' complicato, per il mio carattere,» rispose il pastore con ironia, «allora di', perché credi che ci siamo incontrati?»
«Perché siamo uomini. Per questo, io credo. Gli uomini si incontrano, prima o poi.»
«Già,» lo interruppe con sarcasmo l'altro, «l'ho sentita altre volte questa litania. Gli uomini si incontrano sempre, un giorno o l'altro. Si incontrano sempre, è vero. Per sistemarsi i conti fra loro. Si incontrano per derubarsi, per violentarsi, per scannarsi… Anche Caino e Abele si sono incontrati.»
«Non volevo dire, incontrarsi a quel modo. Volevo dire, incontrarsi come ci siamo incontrati noi. Nudi e soli. Soli con noi stessi, con la nostra storia e la nostra esperienza di uomini nudi.»
«Bisogna arrivare a QUESTO, dunque - perché gli uomini si incontrino?» mormorò il pescatore atterrito.
«Sì. O QUESTO o la paura di QUESTO,» scandì il minatore.
Il pastore si fermò, piantandosi ritto in mezzo alla strada. Strinse i denti e batté con ira un pugno sul palmo della mano. Mosse le labbra come se sputasse veleno. Urlò: «Questo… cosa vuol dire QUESTO? Floris Efisio, parla chiaro. Questo vuol dire morte, no? Hai paura, tu, a dire pane al pane e vino al vino? Io non sono poeta e ci piscio sulle belle parole! Tu vuoi dire che gli uomini si incontrano solo nella morte o per paura della morte. E' questo che vuoi dire? E' questo?»
«Sì. Questo volevo dire. Questa è la mia risposta. Avevo paura della mia risposta,» tacque, poi soggiunse: «Coccoi Sebastiano, uomo di pietra che pisci sulle belle parole: ce l'hai, tu, adesso, pronta, la tua risposta?»
Il pastore sentì sbollire tutta la sua ira. Si lasciò andare disteso nel mare placato della sua coscienza. Trascorse il tempo di una vita. Allora parlò. Disse: «Ho capito. Ho trovato anch'io la mia risposta. Ogni uomo deve trovare dentro di sé la propria risposta.»
«E qual'è?» Chiese il pescatore con un mezzo sorriso.
L'altro non raccolse il tono ironico. Disse: «Ci sono risposte che sono uguali per tutti gli uomini. Come quella di Floris Efisio. Io so che è così anche per Orrù Gavino, che ora è nella sua vigna. E anche per te, Atzori Giosué, pescatore di paludi…»
«Orrù Gavino…» mormorò con dolcezza il minatore, ricordando.
«Orrù Gavino… già,» ripeté il pescatore, «ma se gli uomini si incontrano, perché dopo vogliono separarsi? Perché si separano, dopo che si sono incontrati?»
«Quando gli uomini si sono incontrati, non restano più soli - anche se si separano,» disse il pastore. E si sentì contento di aver dato la sua risposta per primo, una risposta che egli desiderò fosse di tutti.
«Sì,» si affrettò a dirgli il minatore, «sì Coccoi Sebastiano. Quando gli uomini si sono incontrati, non si separano più, anche quando si sono lasciati. Si ritrovano tutti in ognuno di loro. In ogni uomo ci sono tutti gli uomini del mondo e tutte le stelle del cielo.»
«E qui dentro ci sono anche tutte le pietre e le speranze del mio monte!» Esclamò il pastore, battendosi il pugno sul petto.
Non si era ancora spenta l'eco delle sue parole, quand'egli, sollevando lo sguardo, vide le prime propaggini della montagna, chiare e nitide nell'azzurro. Le nubi diradavano sbrindellate dalle guglie di granito.
«Tu pure sei arrivato, Coccoi Sebastiano?» chiese il pescatore con una punta d'invidia. E il suo pensiero corse lungo la strada grigia che proseguiva oltre le nebbie del monte, scomparendo nella linea dell'orizzonte.
Fecero insieme ancora un tratto di cammino. All'improvviso il pastore esclamò eccitato: «Ecco, lo riconosco… questo viottolo, la scorciatoia,» e vi pose il piede sopra.
Quando si voltò per salutare i compagni li vide già lontani, evanescenti, come nell'immagine sfocata di un sogno. Levò in alto la mano, pronunciò parole di affetto. E sentì un dolore nuovo acutissimo, vedendo i suoi due ultimi compagni allontanarsi, scomparire.
Volse le spalle per ritrovare se stesso. Desiderò piangere, per la prima volta. Ma sollevò in alto la faccia e riconobbe il suo monte. Lo riconobbe nelle pietre piovute dal cielo coi fulmini, negli anfratti profondi come gola di serpe, nelle macchie irte di cisto e di lentisco, nelle rade elci curve al vento, nei mentastri odorosi e nelle velenose euforbie. Ne sentì la solitudine e il silenzio - che fanno il cuore dell'uomo duro fragile tagliente come vetro.
Salì verso la radura dove il suo gregge meriggiava, nel recinto di pietre e di rami spinosi. A mezza salita sedette su uno sperone di roccia. Sotto di lui tumultuava l'immenso mare di pietra, ondeggiando immoto con aguzze creste, ricadendo in un silenzioso scroscio di taglienti lame di granito.
Desiderò - come altre volte - di diventare anch'egli una pietra fra le pietre infitte ai piedi del monte. «Il mio destino è nella pietra,» pensò con un gemito, «a che servono, qui, in questo monte, i sogni e le speranze dell'uomo?» Ma ricordò i suoi compagni e vinse il peso della solitudine. Pensò: «Verrà il giorno in cui le pietre diverranno terra. E la terra darà germogli.»
Si scosse e si levò. Si inerpicò verso la radura, che gli apparve vicina. Là, decise di attendere quel giorno.
Proseguirono di buona lena, camminando gomito a gomito, ognuno chiuso nei propri pensieri.
La strada penetrava nella foschia, come un fuso in un batuffolo di lana candida appena carminata. Qualche lieve frangia veleggiava sospesa incontro ai viandanti. Il pescatore, passando, ne disfece una con la mano. Disse: «Lo sai, Floris Efisio, che la nebbia è l'anima delle paludi?»
«Le tue paludi… Come sono le tue paludi, Atzori Giosué?» chiese l'altro.
«Sono come un mare buono. Anche un bambino ci può giocare, senza danno. Il mare, invece fa paura.»
«Perché fa paura il mare? E' per questo che tu non entri nel mare a pescare…»
«Ci ho provato qualche volta. Tu non sai come è infido il mare. Tutto ciò che è rovina e danno viene dal mare. Vento e pioggia vengono dal mare. Il sale che ti brucia gli occhi, che inaridisce erbe e piante. Truffatori e ladri vengono dal mare… Il suo fondo è scuro come l'anima del demonio.»
«Io l'ho visto solo da lontano, il mare. Però capisco perché lo temi. Ma tu non temi le tue paludi. Dimmi, come sono le tue paludi?»
L'altro lo guardò stupito. Disse: «Perché vuoi che te ne parli? Che gusto puoi provarci tu, minatore, a sentir parlare delle mie paludi?»
«Una cosa voglio capire meglio, Atzori Giosué: cos'hanno queste tue paludi, perché tu le ami tanto fino a patire la galera, per esse?»
Il pescatore rallentò il passo, per raccogliere meglio i pensieri. Disse: «Non me lo sono mai chiesto. Credevo che tutti gli uomini sapessero perché uno patisce la galera per amore delle sue paludi. Così non mi sono neppure preoccupato di rispondermi.» Si interruppe, guardò in faccia il compagno, gli chiese: «Tu, Floris Efisio, se ti chiedessero perché corri in mezzo al fuoco per salvare tuo figlio, tu, Floris Efisio, ti preoccuperesti di trovare una risposta?»
«No so… forse…»
«Forse… forse per lo stesso motivo ho patito la galera.»
«Ho capito, adesso, Atzori Giosué. Tutti gli uomini vogliono le stesse cose e soffrono per le stesse cose.»
«Sì, Floris Efisio, gli uomini vogliono giustizia, soffrono per la giustizia.»
Parlando si erano spinti fin dove la nebbia costeggiava la strada. Ai margini di essa il pescatore vide i primi ciuffi di falasco. Gli parve di intravvedere un lembo cinereo di laguna, appena increspata dalla maretta, e di udire lo sciabordare dei barchini. «Ho avuto paura di non arrivare,» mormorò, «come ho potuto?»
Il minatore andò con lo sguardo lungo la strada che piegava da un lato, costeggiando il cumulo di nebbie, filando poi diritta chiara fino all'orizzonte. «Sono stanco,» disse a se stesso triste, «ma so anche, ora, che la strada non sarà lunga.» E si rasserenò.
Il pescatore con un guizzo saltò nella melma. Stropicciò con gusto i piedi scalzi nella fanghiglia tiepida, grattandoli sui gusci delle arselle. «Guarda, Floris Efisio, guarda! E' proprio la palude,» disse, voltandosi indietro…
Vide la strada grigia lontana - esile cordicella di palamite - e su di essa scorrere - minuto nodo di lenza - il minatore. Allora si accoccolò sulla terra, com'era sua abitudine antica - con le natiche sopra le calcagna e metà dei piedi infissi nella melma. Nascose la faccia fra le mani appoggiate sulle ginocchia. Stette così immobile, lasciandosi avvolgere dalla carezza umida della nebbia.
Ripensò ai suoi - il giorno più bello della sua vita. Erano forse in duecento, quel giorno, in mezzo alla palude, davanti a tutta la gente accorsa sulla riva, per vedere. C'erano più carabinieri che pesci, quel giorno. I pesci li avevano gettati sulla riva, ai piedi del popolo. Poi avevano dato i polsi alle manette Le donne e i vecchi avevano pianto, quel giorno. E i bambini muti assorti guardavano senza poter capire…
Si scosse di dosso i ricordi agitati. Pensò: «L'uomo non è mai solo, se è in pace con sé,» e si levò sereno. Entrò in acqua, fra canneti e giunchi. Avanzò immergendosi fino alle reni. Vide un grosso cefalo - lo sorprese insonnolito nella melma. Lo agguantò rapido, stringendolo alle branchie. Lo levò in alto. Lo osservò divincolarsi, e sorrise ilare. Dopo, lo lasciò cadere, e lo seguì con lo sguardo allontanarsi guizzando nell'acqua torbida. Pensò: «Un giorno, tutte le acque e tutti gli uomini del mondo saranno liberi.»
Tornò a riva. Ritrovò la breve radura tra i giunchi, dove i barchini di falasco appoggiati ai pali asciugavano alla brezza. Si accoccolò. «L'uomo sarà felice, allora,» mormorò. E attese così quel giorno.
Il minatore si ritrovò solo sulla strada grigia. E ripensò a lei, nel sentiero aperto tra gli ulivi. Ripensò ai compagni, seduti sulle cataste di eucalipto - intorno al pozzo.
Mosse più rapido il passo. Un suono d'organo, venuto da lontano nel tempo, giunse alle sue orecchie. Non ricordava di aver mai udito quel motivo, eppure gli parve noto - gli parve di averlo già vissuto. Ogni nota prendeva forma, era un'immagine che egli ritrovava dentro di sé. Si sforzò di collocare ogni istante - ogni immagine - al proprio posto. Annaspava con dita febbrili nel cumulo dei frammenti che erano stati il mosaico della sua vita…
La prima immagine che si ricompose nitida davanti ai suoi occhi fu il volto dei sedici anni. «Perché? Perché?» Si chiese con angoscia, «perché devono incontrarsi solo così gli uomini?»
Accelerò ancora l'andatura. La strada era lieve scorrevole sotto i suoi piedi. Ritrovò il volto di sua madre. La vide - allora soltanto - come non aveva potuto vederla. Stava dentro la bara aperta, sull'uscio di casa spalancato in un lungo viale di cipressi. Non c'erano fiori, né ceri intorno alla bara - solo un gruppo di donne contadine. Una si era avvicinata. Toccandole i capelli aveva detto: «Peccato, non erano tutti bianchi i suoi capelli.» Le altre assentivano con un mesto dondolio del capo. Dicevano: «Come è bella. Non erano tutti bianchi i suoi capelli.» Lei sentiva e capiva, compiaciuta. «Come vorrei che fosse qui Efisio, adesso a vedermi, adesso che sono così bella,» pensava che se avesse gridato la sua voce sarebbe giunta fin nelle viscere di pietre entro cui suo figlio scavava. Si sforzava di sollevare la testa e di gridare. Rintocchi venivano dal cimitero. Si udivano appena. Le donne contadine presero la bara a spalle e si mossero. Lei vedeva i cipressi a lato sollevarsi giganteschi fino al cielo. «Perché non viene?» Si chiedeva con assillo senza volto, «Forse mi attende là.» Il viale nero pareva interminabile. «Sì,» cercava di placarsi, «deve essere proprio là, ad attendermi.» Tentò inutilmente di guardare avanti, attraverso il varco del cancello che si apriva senza cigolio. «Lo vedrò chino su di me, tra poco.» E con un prodigioso sforzo spalancò gli occhi e gettò un grido… Occhi e bocca si empirono di terra.
Floris Efisio lo sentì allora il grido. Il suo andare divenne corsa. La strada si era fatta più chiara. L'azzurro del cielo più cupo. Era la stessa strada che dalla laveria portava al pozzo. Capì che stava per compiersi il suo destino. «E' questo che tu volevi? E' questo?» Si chiese - ripetendo parole già pronunciate. Non attese risposta. Chiuse gli occhi - non per paura, ma per capire meglio, per vedere meglio.
La strada grigia era finita. Dopo un serpeggiare di tornanti scoscesi, tra cumuli di sterili ghiaie e di velenose euforbie, si spalancava un abisso tagliente, assurdo nell'azzurro senza confini.
Il minatore risentì l'urlo della frana, il ghiaccio del silenzio e l'angoscia del tempo scandito dal martellare del cuore nel buio della pietra. Si tenne immobile, con gli occhi serrati, accoccolato, rattrappito, chiuso, stretto in ogni molecola del suo essere, per ripararsi, per resistere al peso della montagna, per sopravvivere dentro se stesso. Vide allora, per la prima volta, con una chiarezza luminosa. Si percepiva distinto e nitido con ogni suo senso. Fuori si era fatto il nulla. Dentro scoprì un universo animato da immagini sensazioni pensieri, che egli possedeva e che egli aveva ignorato di possedere.
Con animo rinato si accinse a rivivere ogni momento già vissuto, purificato da ogni scoria. Ritrovò persone, oggetti, luoghi, parole in una dimensione nuova. Ritrovò i sedici anni biondi. Ne assaporò gli occhi limpidi e il sorriso dolce. Indugiò intenerito, perché lei lo aveva ripreso per mano, scuotendo indietro i capelli lunghi lisci, avviandosi per il sentiero aperto tra gli ulivi… Era il primo maggio. Il pomeriggio del primo maggio. Le mimose erano in fiore. Egli ne portava un mazzetto all'occhiello della giacca. Lei ne aveva sparse tra i capelli, e tracce di polline aveva nelle guance. La festa si era fatta in una radura sopra un colle. Una sera di danze, di vino, di speranze, di strette di mani, di canti, di liberazione. Una sera con un futuro umano. Un compagno aveva tenuto comizio. C'erano tutti. C'erano i ragazzi, le donne e le fanciulle. Si erano cercati con gli occhi, fra la gente. E si erano trovati, con un sorriso di gioia. Egli si era avvicinato. Erano rimasti ad ascoltare, ai margini della folla, sull'orlo del costone. Lei lo aveva preso per mano, scuotendo indietro i capelli lunghi lisci, avviandosi per il sentiero aperto tra gli ulivi…
Si ritrovò tra i compagni in tuta azzurra, col tascapane a spalla e la lanterna ciondoloni tra le mani. Sedeva sopra le traverse accatastate intorno al pozzo, aspettando in silenzio il turno.
La gabbia, dentro il castello di travi, riapparve gocciolando stille di buio. Scendendo, l'eco della campana vibrò lungo il cavo. «Suona a morto, oggi.» Aveva pensato e detto a uno. Nessuno gli aveva risposto. Aveva risposto poco dopo la frana, in un budello che si allargava formando una bolla. Bisognava armarla e superarla a tutti i costi, la bolla… o sperare che la volta reggesse da sola, per non perdere il filone. Sette erano rimasti insaccati dietro un diaframma di roccia spessa. Si erano stesi da sé soli nella tomba - uno a fianco dell'altro, tenendosi l'un l'altro la mano, con gli occhi aperti nel buio, senza parole da dire o da udire, frenando,soffocando l'inutile pulsare della vita.
Floris Efisio li ritrovò. Li riconobbe. Li contò. Li salutò uno ad uno. C'era posto anche per lui nella sacca. Si distese accanto al settimo. Pensò: «Attenderò con loro. E' qui che io desidero restare. La montagna si aprirà, un giorno. Tutte le montagne si apriranno… e gli uomini vedranno finalmente la luce del sole. Sarà un giorno meraviglioso, quel giorno. L'uomo sarà uomo.»
Narratore e saggista Ugo Dessy ha pubblicato tra l'altro Il Testimone - Fossataro - Cagliari, 1966; L'Invasione della Sardegna - Feltrinelli - Milano, 1969; Stato di Polizia, Giustizia e Repressione - Feltrinelli - Milano, 1970; Sardegna: un'Isola per i militari - Marsilio - Padova, 1972; Il diario dello Stregone di Iknusu - Marsilio - Padova, 1973; La Rivolta dei pescatori di Cabras - Marsilio - Padova, 1973; Quali Banditi? In 3 volumi- Bertani - Verona, 1977; La Maddalena, morte atomica nel Mediterraneo - Bertani - Verona, 1978; I galli non cantano più - Bertani - Verona, 1978; Sardegna: Segni della cultura popolare - Alfa Editrice - Cagliari, 1984; Informazione antimilitarista (antologia) - Livorno 1984; Un grande amore (antologia) - La Spiga - Milano, 1984; SU TEMPUS CHI PASSAT - Vol. I “S’annu de su messaju”- Vol. II “Sa mexina” Alfa Ed. 1989; Educazione popolare come movimento di liberazione - Alfa Ed. 1993; SU TEMPUS CHI PASSAT Vol. III “Artis e fainas” Alfa Ed. 1999; SU TEMPUS CHI PASSAT Vol. IV “Contus e contixeddus” Alfa Ed. 2002.
Dell’Opera di tradizioni popolari SU TEMPUS CHI PASSAT, sono in fase di pubblicazione, i volumi “Is ligendas”, “Usanzias antigas”, “Is festas”, “Sa poesia”, “Piccioccus de crobi”, “Dicius e frastimus”.Infine, è in stampa “Iknusu ‘74”, seconda parte del romanzo “Il diario dello Stregone di Iknusu”.

